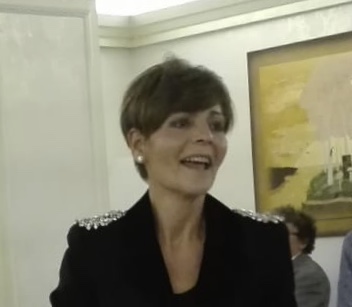Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| Primo semestre Magistrali | 26-set-2016 | 13-gen-2017 |
| Secondo Semestre Magistrali | 27-feb-2017 | 1-giu-2017 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Appelli esami sessione invernale | 16-gen-2017 | 17-feb-2017 |
| Appelli esami sessione estiva | 5-giu-2017 | 7-lug-2017 |
| Appelli esami sessione autunnale | 28-ago-2017 | 15-set-2017 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione autunnale | 30-nov-2016 | 1-dic-2016 |
| Sessione invernale | 5-apr-2017 | 7-apr-2017 |
| Sessione estiva | 11-set-2017 | 13-set-2017 |
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| Vacanze natalizie | 23-dic-2016 | 5-gen-2017 |
| Vacanze pasquali | 14-apr-2017 | 18-apr-2017 |
| Vacanze estive | 7-ago-2017 | 25-ago-2017 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Docenti
 lara.bordignon@univr.it
lara.bordignon@univr.it
 silvano.corbella@univr.it
silvano.corbella@univr.it
Mussini Mauro
 mauro.mussini@univr.it
mauro.mussini@univr.it
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
2° Anno Attivato nell'A.A. 2017/2018
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Economia del settore non profit (2017/2018)
Codice insegnamento
4S00421
Docente
Coordinatore
Crediti
6
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
Periodo
Secondo Semestre Magistrali dal 26-feb-2018 al 25-mag-2018.
Obiettivi formativi
L'insegnamento ha come obiettivo fondamentale quello di consentire allo studente di comprendere in maniera rigorosa il ruolo specifico che le organizzazioni non profit possono svolgere all’interno dei sistemi economici avanzati contemporanei e di analizzarne i rapporti funzionali con realtà statali e for-profit. Tale obiettivo viene perseguito sia attraverso l’illustrazione, mediante una serie di lezioni frontali, delle principali categorie analitiche sviluppate negli ultimi anni in seno alla teoria economica del settore non profit (prima parte), che facendo riferimento ai più importanti risultati ottenuti a livello empirico dalla letteratura internazionale sul tema (seconda parte). Questi ultimi verranno presentati anche mediante la discussione in aula di una serie di scenari di interazione strategica alternativi in grado di gettare luce sui principali punti di forza e di debolezza delle organizzazioni non profit rispetto ad organizzazioni di altra natura. Particolare attenzione, in questa seconda parte del corso, verrà riservata alle problematiche associate alla presenza, nelle interazioni tra domanda e offerta, di asimmetria informativa, incompletezza contrattuale ed eterogeneità motivazionale (con specifico riferimento alla rilevanza del consumo etico, dal lato della domanda). La discussione in aula di tali tematiche è finalizzata a rafforzare le capacità analitiche dello studente in ordine alle peculiari funzioni a cui le organizzazioni senza fine di lucro sono in grado di assolvere all’interno di una moderna economia di mercato.
Programma
I principali punti di programma sono i seguenti:
- Perchè esiste il settore non profit, all'interno di un'economia di mercato? La teoria del 'fallimento dello Stato' di Weisbrod e la teoria del 'fallimento del mercato' di Hansmann.
- Verso una spiegazione non residualistica dell'universo non profit: dilemmi dell'azione collettiva, fiducia e comportamenti pro-sociali.
- Il commercio equo e solidale (fair trade) e la sua compatibilità con i principi dell'economia di mercato.
- Beni posizionali, beni relazionali e accumulazione di capitale sociale (di tipo bridging vs bonding) e capitale civico.
- Il fundraiser come intermediario tra donatori e organizzazioni non profit. Etica del Fundraising: i principali codici etici adottati in Italia e a livello internazionale.
Durante il corso, il materiale didattico specifico relativo alle singole lezioni viene reso disponibile dal docente prima di ogni lezione sul portale dell'E-Learning di ateneo, nello spazio online dedicato all'insegnamento. Oltre al materiale didattico fornito dal docente, i testi in programma sono i seguenti:
- Musella M., D’Acunto S., 2000, Economia politica del non profit, Giappichelli, Torino.
- Sacco P.L., Zarri L., 2006, Perché esiste il settore non profit?, Filosofia e Questioni Pubbliche.
- Ecchia G., Zarri L., 2005, Capitale sociale e accountability: il ruolo del bilancio di missione nella governance delle organizzazioni non profit, in Fazzi L. e Giorgetti G. (a cura di), Il bilancio sociale per le organizzazioni nonprofit. Teoria e pratica, Guerini e Associati, Milano.
- Becchetti L., Paganetto L., 2003, Finanza etica. Commercio equo e solidale, Donzelli editore.
Durante il corso, verranno inoltre inseriti nella pagina E-Learning dell’insegnamento e commentati in aula diversi articoli di attualità economica riconducibili ai temi affrontati in aula. Si invitano tutti gli studenti (frequentanti e non) a procurarsi i testi indicati e ad iscriversi al corso accedendo al portale dell'E-Learning.
| Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ECCHIA G. - ZARRI L. | Capitale sociale e accountability: il ruolo del bilancio di missione nella governance delle organizzazioni non profit, in FAZZI L. - GIORGETTI G. (a cura di), Il bilancio di missione nelle organizzazioni non profit. Teoria e pratica | Guerini & Associati | 2005 | 888335611X | |
| MUSELLA M.-D'ACUNTO S. | Economia politica del non profit | Giappichelli | 2000 | ||
| BECCHETTI L.-PAGANETTO L. | Finanza etica. Commercio equo e solidale. La rivoluzione silenziosa della responsabilità sociale | Donzelli | 2003 | 8879898132 | |
| Sacco P.L., Zarri L. | Perché esiste il settore non profit?, in Filosofia e Questioni Pubbliche | Il Saggiatore | 2006 |
Modalità d'esame
L’esame consiste in una prova orale a fine corso. In linea con gli obiettivi formativi del corso, tale prova mira ad accertare l’avvenuta acquisizione, da parte dello studente, della capacità di comprendere in maniera rigorosa il ruolo specifico delle organizzazioni non profit all’interno dei sistemi economici avanzati contemporanei e di analizzarne i rapporti funzionali con realtà statali e for-profit. Lo studente dovrà dare prova di tali capacità di analisi attraverso il ricorso alle principali categorie concettuali sviluppate negli ultimi anni in seno alla teoria economica del settore non profit (prima parte del corso), nonché facendo riferimento ai più importanti risultati ottenuti a livello empirico dalla letteratura sul tema e discussi in aula durante il corso con riferimento a scenari di interazione strategica alternativi (seconda parte).
Nel corso del semestre, vi è inoltre la possibilità, sia per gli studenti frequentanti che per i non frequentanti, di preparare, a livello di gruppo (con gruppi che saranno composti da 2 o 3 studenti), una presentazione orale o una discussione (punteggio assegnabile a ciascuno studente: da 0 a 3 punti, da sommare al voto dell’esame) su un tema riconducibile al programma dell’insegnamento. Per indicazioni puntuali relativamente a questa possibilità, si veda, a inizio semestre, il materiale didattico relativo alla prima lezione, nello spazio online riservato all'insegnamento all'interno della piattaforma E-Learning di ateneo.
Tipologia di Attività formativa D e F
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Laboratorio Excel Avanzato (Verona) | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Laboratorio Excel (Verona) | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e a breve anche tramite l'app Univr.
Esercitazioni Linguistiche CLA
Prova finale
La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.
Elenco delle proposte di tesi e stage
| Proposte di tesi | Area di ricerca |
|---|---|
| Analisi dell'Impatto della Regolamentazione: potenziale e applicazioni concrete | Argomenti vari |
| Costi e benefici della nuova linea ferroviaria Torino-Lione | Argomenti vari |
| Costi e benefici del sistema di rilevazione della velocità “tutor” sulle autostrade italiane | Argomenti vari |
| Il futuro del corporate reporting (COVID19) | Argomenti vari |
| I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 | Argomenti vari |
| La stima del valore della qualità delle strutture ospedaliere attraverso la valutazione contingente | Argomenti vari |
| La valutazione dell’impatto occupazionale dei grandi progetti | Argomenti vari |
| Valutazioni d'azienda | Argomenti vari |
Tirocini e stage
Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) di area economica è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.
Per informazioni specifiche, consultare il servizio di Segreteria studenti appositamente dedicato a Stage.

 045 802 8292
045 802 8292