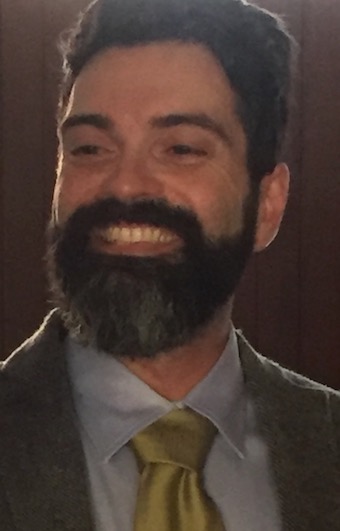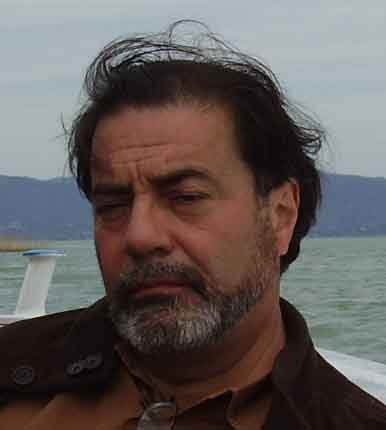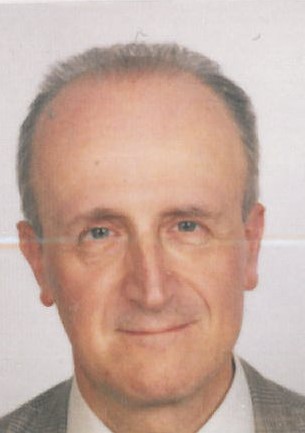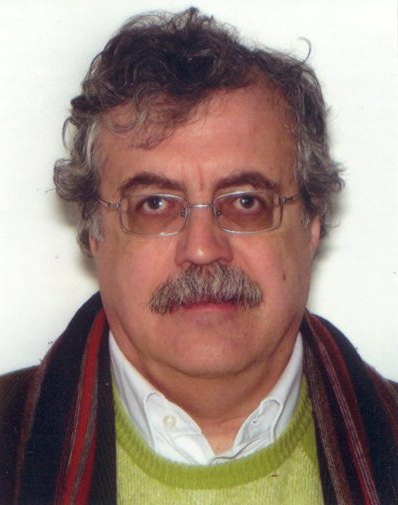Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| Primo semestre | 4-ott-2010 | 22-gen-2011 |
| Secondo semestre | 28-feb-2011 | 4-giu-2011 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione Invernale | 24-gen-2011 | 26-feb-2011 |
| Sessione Estiva | 6-giu-2011 | 30-lug-2011 |
| Sessione Autunnale | 1-set-2011 | 30-set-2011 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione di laurea invernale | 8-mar-2011 | 9-mar-2011 |
| Sessione di laurea estiva - I appello | 14-giu-2011 | 15-giu-2011 |
| Sessione di laurea estiva - II appello | 12-lug-2011 | 13-lug-2011 |
| Sessione di laurea autunnale - I appello | 18-ott-2011 | 19-ott-2011 |
| Sessione di laurea autunnale - II appello | 29-nov-2011 | 30-nov-2011 |
| Sessione laurea invernale | 27-mar-2012 | 28-mar-2012 |
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| Festa di Ognissanti | 1-nov-2010 | 1-nov-2010 |
| Festa dell'Immacolata Concezione | 8-dic-2010 | 8-dic-2010 |
| Vacanze di Natale | 24-dic-2010 | 8-gen-2011 |
| Vacanze di Pasqua | 21-apr-2011 | 26-apr-2011 |
| Festa della Liberazione | 25-apr-2011 | 25-apr-2011 |
| Festa del Lavoro | 1-mag-2011 | 1-mag-2011 |
| Festa del Santo Patrono di Verona S.Zeno | 21-mag-2011 | 21-mag-2011 |
| Festa della Repubblica | 2-giu-2011 | 2-giu-2011 |
| Vacanze Estive | 8-ago-2011 | 15-ago-2011 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria Corsi di Studio Scienze Umane.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami
Docenti
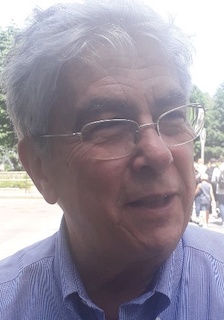
Avezzu' Guido
 guido.avezzu@univr.it
guido.avezzu@univr.it
 augusto.barbi@univr.it
augusto.barbi@univr.it
 evita.calabrese@univr.it
evita.calabrese@univr.it

Chiecchi Giuseppe
 giuseppe.chiecchi@univr.it
giuseppe.chiecchi@univr.it
 +39 045802 8117
+39 045802 8117
 giorgio.franck@univr.it
giorgio.franck@univr.it
 linda.napolitano@univr.it
linda.napolitano@univr.it
 domenico.secondulfo@univr.it - domenico.secondulfo3@gmail.com
domenico.secondulfo@univr.it - domenico.secondulfo3@gmail.com
 gianmaria.varanini@univr.it
gianmaria.varanini@univr.it
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
2° Anno Attivato nell'A.A. 2011/2012
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Un insegnamento a sceltaUn insegnamento a scelta tra i seguenti3° Anno Attivato nell'A.A. 2012/2013
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Un insegnamento a sceltaUn insegnamento a scelta tra i seguenti| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Da quattro a sette insegnamenti a scelta tra i seguenti, di cui per 12 cfu al II anno, 24 al III annoDue o tre insegnamenti a scelta tra i seguenti(l'insegnamento di storia comunque diverso da quello scleto per la base) di cui per 6 cfu al II anno , 12 cfu al III annoLegenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Storia della filosofia A (i) (2010/2011)
L'insegnamento è organizzato come segue:
Obiettivi formativi
Oltre a fornire un quadro generale dei principali autori e scuole della filosofia antica e medievale, s’intende formare all’uso della terminologia filosofica propria ed insegnare l’uso critico del testo originale, per l’acquisizione di problemi e concetti filosofici centrali.
Programma
Prerequisiti: La conoscenza preliminare della storia della filosofia antica (VI sec. a.C.-529 d.C.) del greco antico e del latino costituisce certo una facilitazione, ma non è obbligatoria. Sono richiesti piuttosto attenzione all’indagine lessicale e inclinazione alla lettura critica del testo filosofico.
Modulo: I MODULO PARTE (I)
-------
Contenuto del corso: Titolo “Eudaimonìa: la felicità degli antichi”
Il corso intende esplorare anzitutto la nozione antica di felicità (eudaimonìa): a partire dalla subordinazione dell’uomo ai capricci della divinità o del Caso nei poemi omerici e nella tragedia, attraverso Democrito e la sua nozione di tranquillità interiore (euthymìa), fino a Socrate e alla sua valorizzazione filosofica della felicità come consapevolezza ed esercizio del proprio autentico sé (psyché). Proseguendo poi con Platone, con la sua identificazione di virtù e felicità e con la sua concezione del filosofo come garante della felicità pubblica. Soffermandosi su Aristotele e sulla sua nozione della felicità quale esercizio dell’èrgon (dell’attività) proprio dell’uomo, sulla felicità virtuosa del saggio, sull’amor di sé, sull’amicizia e la felicità della contemplazione. Infine valutando la via alla felicità proposta da Cinici e Cirenaici.
Testi di riferimento:
a) Parte generale: E. BERTI, Storia della filosofia: Antichità e Medioevo, Roma-Bari 1991 (ed edizioni successive), Capp. I-VIII (comunque fino al neoplatonismo compreso);
b) testo critico: F. DE LUISE – G. FARINETTI, Storia della felicità. Gli antichi e i moderni, Torino, Einaudi PBE 2001, pp. XI-106 (questo testo, essendo fuori catalogo, verrà accluso in fotocopia alla dispensa di cui al punto c);
c) dispensa con fotocopie di testi originali, messe a disposizione degli studenti.
Modulo: II MODULO PARTE (P)
-------
Contenuto del corso: Titolo: “Eudaimonìa, beatitudo: la felicità degli antichi e dei medievali”
Il corso intende esplorare anzitutto la nozione antica di felicità (eudaimonìa): a partire dalla subordinazione dell’uomo ai capricci della divinità o del Caso nei poemi omerici e nella tragedia, attraverso Democrito e la sua nozione di tranquillità interiore (euthymìa), fino a Socrate e alla sua valorizzazione filosofica della felicità come consapevolezza ed esercizio del proprio autentico sé (psyché). Proseguendo poi con Platone, con la sua identificazione di virtù e felicità e con la sua concezione del filosofo come garante della felicità pubblica. Soffermandosi su Aristotele e sulla sua nozione della felicità quale esercizio dell’èrgon (dell’attività) proprio dell’uomo, sulla felicità virtuosa del saggio, sull’amor di sé, sull’amicizia e la felicità della contemplazione. Infine, valutando la via alla felicità proposta da Cinici e Cirenaici, da epicureismo, stoicismo, scetticismo e neoplatonismo, si avrà chiaro che l’eudaimonìa è un cardine costante, pur diversamente declinato, dell’etica ed antropologia greche.
Il Medioevo reinterpreta l’idea di felicità alla luce della prospettiva cristiana: essa diviene anzitutto salvezza del singolo innanzi a Dio, e inoltre salvezza dell’anima, non del corpo. Si ha uno spostamento anche terminologico, dall'eudaimonìa greca alla beatitudo medievale. Eppure la felicità condiziona l'etica medievale in modo massiccio e pervasivo: essa è in modo pressoché esclusivo un'etica della felicità. E quindi un'etica del fine, poiché la beatitudo, cioè la salvezza, non si poneva come reale possibilità per l'uomo, ma come essenziale completamento della sua natura e, in questo, dello stesso progetto di Dio. Con un'unica eccezione: l'etica del dovere assoluto di Anselmo d'Aosta. Oltre a fornire una panoramica generale del pensiero medievale, il modulo si soffermerà sul confronto tra questi e Tommaso, campione invece dell'etica della felicità di matrice aristotelica.
Testi di riferimento:
II Modulo (6 cfu) (in collaborazione con altri docenti, fra cui, principalmente, il dr. Carlo Chiurlo)
a) Parte generale: I. SCIUTO, L'etica nel Medioevo, Einaudi, Torino 2007.
b) testo: TOMMASO D’AQUINO, La felicità, Bompiani, Milano 2010 (con testo a fronte) (parti scelte)
c) dispensa con fotocopie di testi originali, messe a disposizione degli studenti.
Metodi didattici: Il corso prevede lezioni frontali con presentazione introduttiva degli autori e successiva lettura diretta di testi sul tema monografico e discussione comune; perciò è utile e dunque auspicabile, benché ovviamente non obbligatoria, la frequenza.
Per i non frequentanti il programma rimane lo stesso, ma essi dovranno contattare la docente per concordare un testo personalizzato (a seconda delle proprie conoscenze pregresse, della propria formazione curricolare e dei propri interessi), il cui studio compensi la mancata frequenza del corso.
Modalità d'esame
Lo studente verrà interrogato oralmente, invitato anche alla lettura ed al commento dei passi letti insieme in classe.
Per le parti generali (manuale di storia della filosofia antica e di storia della filosofia medievale) è previsto un accertamento tramite compito scritto: 3 domande a risposta aperta, di una ventina di righe, da redigersi in Aula, in date comunicate preventivamente per ogni appello d’esame; il voto riportato farà media con il successivo colloquio orale.
Chi lo desiderasse potrà presentare, per la parte monografica del corso, una breve relazione scritta (5-10 cartelle da presentarsi almeno una settimana prima dell’esame) sui temi e testi discussi in classe: la relazione sarà poi discussa oralmente durante l’esame.
Casi specifici:
a) gli studenti che hanno già sostenuto la Parte generale di Storia della filosofia antica, oppure di Storia della filosofia A, potranno sostituire questa parte con testi ad hoc concordati con la docente. Per essi è comunque a disposizione un’ulteriore specifica Dispensa; essi sono esentati dall’accertamento scritto e sosterranno solo il colloquio orale;
b) gli studenti di Beni Culturali, che portano il corso per soli 3 crediti, porteranno solo la Parte generale e la dispensa;
c) i triennalisti del vecchio ordinamento (fino all’AA 2007-8) porteranno, per Storia della filosofia (A) solo 6 crediti e dunque, a loro scelta, o questo 1° modulo, oppure il 2° relativo alla Storia della filosofia medievale (questo 2° Modulo, però, non mutua il corso specifico di Storia della filosofia medievale).
Tipologia di Attività formativa D e F
Insegnamenti non ancora inseriti
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e a breve anche tramite l'app Univr.
Tutorato per gli studenti
Gli iscritti al CdS in Filosofia possono rivolgersi al personale docente docente nell'orario di ricevimento per parlare delle eventuali difficoltà di cui fanno esperienza nel cammino formativo, nell’organizzazione del piano didattico, nella preparazione degli esami e in tutte le altre situazioni in cui può essere utile farsi aiutare nelle proprie scelte o ricevere un consiglio da persone consapevoli dei vari dettagli della vita accademica, dei processi e dell’architettura del CdS.
I docenti indicati come tutor del corso di laurea in Filosofia sono:
- prof. Federico Leoni;
- prof. Davide Poggi;
- prof.ssa Ilaria Possenti.
Nel quadro del programma di TUTORATO, il Dipartimento di Scienze Umane ha inoltre deciso di utilizzare l’esperienza di alcuni iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche per offrire un supporto che sia il più vicino possibile a chi frequenta il CdS triennale, sulla base della loro diretta esperienza.
Tali Tutor studenteschi forniranno un servizio di orientamento, sia in ingresso (vòlto a favorire un migliore inserimento nei Corsi di Studio, ovviando alle difficoltà e agli ostacoli che il passaggio dalla Scuola Superiore all’Università inevitabilmente comporta), sia in itinere, così da offrire un servizio di sostegno che sappia adeguatamente interpretare e rispondere alle esigenze di formazione e professionalizzazione, nonché alla sensibilità di chi frequenta i CdS filosofici.
Tra i compiti e le attività previste vi sono:
- Sostegno nella compilazione dei piani didattici, consulenza nella risoluzione di problemi amministrativi (reperimento informazioni sul sito web di Ateneo);
- Individuazione e suggerimento di Uffici e Responsabili competenti in relazione alle questioni segnalate, etc.;
- Aiuto per una migliore e più agile gestione del proprio iter formativo (supporto in merito all’accesso e alla fruizione della didattica on-line attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Ateneo);
- Orientamento delle/degli studenti (inclusa la scelta del docente per la tesi) in vista della prova finale di laurea;
- Svolgere attività di orientamento delle future matricole (su appuntamento via Zoom) coordinata dall’Ufficio Orientamento, anche tramite incontri nei mesi di settembre e ottobre;
- Gestione delle pagine social dedicate alle/agli studenti;
- Tutorial a distanza per supporto metodo di studio/tesi;
- Orientamento della/o studente all’uso del supporto prodotto dal sistema bibliotecario di Ateneo e aiuto alle/ai laureandi per reperire le fonti bibliografiche in caso consultazione materiale bibliografico non disponibile on-line;
- Indagine per la rilevazione di difficoltà dovute all'emergenza in corso;
- Tutorial per il sito del CdS di riferimento;
- Diffusione/pubblicizzazione di comunicazioni/informazioni di maggior importanza/utilità relativamente al CdS e alle sue attività/iniziative (bandi di tutorato/bandi di internazionalizzazione/etc.).
I Tutor studenteschi, tramite la casella di posta elettronica istituzionale, cercheranno di raggiungere le matricole per organizzare insieme una serie di colloqui informali e programmare eventuali iniziative sotto la supervisione dei Tutor accademici.
Per l'a.a. 2023-2024 sono stati nominate come Tutor per il CdS in Filosofia
- Cristian Meneghetti, cristian.meneghetti@studenti.univr.it disponibilità ricevimento: il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
- Michela Marcomini, michela.marcomini@studenti.univr.it disponibilità ricevimento: il giovedì dalle 15.00 alle 16.00
I ricevimenti si terranno in presenza previo appuntamento via e-mail presso la Sala Seminari 2, secondo piano del Palazzo di Lettere.
Eventuali variazioni di giorno e/o orario saranno comunicate con il dovuto anticipo mediante avvisi sulla pagina web di Ateneo.
Esercitazioni Linguistiche CLA
Gestione carriere
Guide operative per lo studente
In questa pagina lo studente potrà trovare delle guide operative, utili al completamento del proprio percorso universitario, che vanno ad integrare quanto già indicato nei Regolamenti didattici del CdS.
1- Qui si possono reperire indicazioni in merito ai riconoscimenti di carriera, ai crediti a libera scelta per lo studente e alle certificazioni linguistiche per gli studenti iscritti ai CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umane a partire dalla coorte 2022 (le indicazioni contenute nella Guida entrano in vigore dal 29 marzo 2023 e sono retroattive solo se a favore dello studente);
2 - Qui si possono reperire indicazioni in merito ai riconoscimenti di carriera, ai crediti a libera scelta per lo studente e alle certificazioni linguistiche per gli studenti iscritti ai CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umane a partire dalla coorte 2014 (le indicazioni contenute nella Guida entrano in vigore dal 29 aprile 2020 e sono retroattive solo se a favore dello studente);
3 - Qui si possono reperire indicazioni in merito al conseguimento dei crediti a libera scelta (Crediti D e F) per gli studenti iscritti ai i CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umane fino alla coorte 2013 (le indicazioni contenute nella Guida entrano in vigore dal 23 febbraio 2011 e sono retroattive solo se a favore dello studente).
Documenti
| Titolo | Info File |
|---|---|
|
|
pdf, it, 325 KB, 02/05/23 |
|
|
pdf, it, 212 KB, 02/05/23 |
|
|
pdf, it, 131 KB, 02/05/23 |
Prova Finale
Per conseguire la laurea in Filosofia, la/lo studente dovrà superare una prova finale. Essa potrà avvenire dopo almeno venti giorni dal superamento delle prove di valutazione relative a tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto dal proprio piano di studi.
La prova finale, cui sono attribuiti 6 CFU, consiste in un elaborato scritto volto ad approfondire una tematica concordata colla/col relatrice/relatore. La tematica dell’elaborato dovrà essere inerente al curriculum della/o candidata/o. La lunghezza dell’elaborato dovrà essere compresa tra venti e trenta cartelle. La/lo studente dovrà avvalersi della supervisione della/o relatrice/relatore, che può essere qualunque docente appartenente all’Ateneo, incluse/i le/i docenti a contratto. La/lo studente dovrà aver superato almeno un esame afferente al settore scientifico-disciplinare di appartenenza della/o relatrice/relatore. Non è prevista la figura della/o correlatrice/correlatore.
L’elaborato potrà essere redatto anche in lingua diversa dall’italiano, previa approvazione della/o relatrice/relatore e del Collegio Didattico, ma la discussione dovrà comunque essere condotta in italiano. La/lo studente potrà ritirarsi dall’esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto. Il Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce le procedure alle quali attenersi nel caso in cui la/il candidata/o non consegua il punteggio minimo richiesto.
La discussione della prova finale avviene in un periodo di tempo che precederà la proclamazione. Il giorno e l’orario preciso della discussione verranno comunicati alla/o laureanda/o dal/la propria/o relatrice/relatore.
La discussione sarà effettuata con una Commissione Istruttoria composta dal/la relatrice/relatore della/o laureanda/o ed un/a altra/o docente, e potrà avvenire in modalità telematica nel caso del protrarsi dell’emergenza da SARS-CoV-2. Superata la discussione della tesi con la Commissione Istruttoria, la proclamazione con comunicazione del voto di laurea avverrà nel periodo indicato nel calendario didattico. Il giorno, l’ora e le modalità di proclamazione saranno resi noti con la pubblicazione del Calendario Lauree commissioni Triennali.
La commissione dispone di centodieci punti; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110, mentre il voto di partenza è dato dalla media ponderata dei voti degli esami. Il voto viene assegnato dalla commissione in assenza della/o candidata/o e di ogni altro estraneo. Nell’assegnazione del voto alla prova finale, la commissione, valutato anche il curriculum della/o candidata/o, si atterrà ai seguenti criteri, attribuendo:
- fino a cinque punti per la dissertazione;
- in rispetto, e ampliamento, di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale, il Collegio Didattico di Filosofia incentiva l’internazionalizzazione assegnando 2 (due) punti su 110 aggiuntivi alle/agli studenti che abbiano conseguito almeno 2 CFU all’estero;
- un punto per il compimento in corso degli studi;
- un punto se la/lo studente ha proseguito al II anno nel corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno.
Nel caso in cui la/il candidata/o abbia ottenuto il massimo dei voti, la commissione può concedere, all’unanimità, la distinzione della lode.
Documenti
| Titolo | Info File |
|---|---|
|
|
pdf, it, 99 KB, 13/10/23 |
|
|
pdf, it, 101 KB, 10/04/24 |