Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sem. 1A | 25-set-2017 | 11-nov-2017 |
| Sem. 1B | 13-nov-2017 | 20-gen-2018 |
| Sem. 2A | 26-feb-2018 | 21-apr-2018 |
| Sem. 2B | 23-apr-2018 | 9-giu-2018 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione d'esame invernale | 22-gen-2018 | 24-feb-2018 |
| Sessione d'esame estiva | 11-giu-2018 | 28-lug-2018 |
| Sessione d'esame autunnale | 27-ago-2018 | 22-set-2018 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione estiva | 16-lug-2018 | 21-lug-2018 |
| Sessione autunnale | 12-nov-2018 | 17-nov-2018 |
| Sessione invernale | 1-apr-2019 | 6-apr-2019 |
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| Festa di Ognissanti | 1-nov-2017 | 1-nov-2017 |
| Festa dell'Immacolata | 8-dic-2017 | 8-dic-2017 |
| Vacanze di Natale | 22-dic-2017 | 7-gen-2018 |
| Vacanze di Pasqua | 30-mar-2018 | 3-apr-2018 |
| Festa della liberazione | 25-apr-2018 | 25-apr-2018 |
| Festa del lavoro | 1-mag-2018 | 1-mag-2018 |
| Festa del Santo Patrono - S. Zeno | 21-mag-2018 | 21-mag-2018 |
| Festa della Repubblica | 2-giu-2018 | 2-giu-2018 |
| Vacanze Estive | 13-ago-2018 | 18-ago-2018 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria Corsi di Studio Culture e Civiltà.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami
Docenti
 angela.alaimo@univr.it
angela.alaimo@univr.it
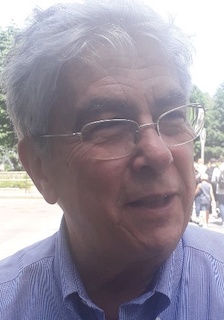
Avezzu' Guido
 guido.avezzu@univr.it
guido.avezzu@univr.it
 augusto.barbi@univr.it
augusto.barbi@univr.it

Bassetti Massimiliano
 massimiliano.bassetti@univr.it
massimiliano.bassetti@univr.it
 045802 8376
045802 8376
 evita.calabrese@univr.it
evita.calabrese@univr.it
Carnero Roberto
 roberto.carnero@univr.it
roberto.carnero@univr.it
 alberto.cavarzere@univr.it
alberto.cavarzere@univr.it

Chiecchi Giuseppe
 giuseppe.chiecchi@univr.it
giuseppe.chiecchi@univr.it
 +39 045802 8117
+39 045802 8117
 federica.gonzato@univr.it
federica.gonzato@univr.it
 elisa.lerco@univr.it
elisa.lerco@univr.it
 francesco.lupi@univr.it
francesco.lupi@univr.it

Mastrocinque Attilio
 attilio.mastrocinque@univr.it
attilio.mastrocinque@univr.it
 +39 045802 8386
+39 045802 8386
 flavia.palma@univr.it
flavia.palma@univr.it

Pasini Roberto
 pasini.roberto@univr.it
pasini.roberto@univr.it
 +39 045802 8121
+39 045802 8121
Peresani Marco
 dino.piovan@univr.it
dino.piovan@univr.it

Pozzo Riccardo
 riccardo.pozzo@univr.it
riccardo.pozzo@univr.it
 +390458028053
+390458028053
 alberto.scandola@univr.it
alberto.scandola@univr.it
Tani Stefano
 stefano.tani@univr.it
stefano.tani@univr.it
 +39 045802 8110
+39 045802 8110
 sonia.trovato@univr.it
sonia.trovato@univr.it
 gianmaria.varanini@univr.it
gianmaria.varanini@univr.it
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Un insegnamento a scelta2° Anno Attivato nell'A.A. 2018/2019
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Letteratura latina (i)
Due insegnamenti a sceltaUn insegnamento a sceltaUn insegnamento a scelta3° Anno Attivato nell'A.A. 2019/2020
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Un insegnamento a sceltaTre insegnamenti a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Un insegnamento a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Letteratura latina (i)
Due insegnamenti a sceltaUn insegnamento a sceltaUn insegnamento a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Un insegnamento a sceltaTre insegnamenti a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Tipologia di Attività formativa D e F
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Estetica (p) | D |
Markus Georg Ophaelders
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° 3° | Il cristianesimo delle origini | F |
Augusto Barbi
(Coordinatore)
|
|
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° 3° | Archeologia e storia dell'arte greca e romana (i) | D |
Giuliana Maria Facchini
|
| 1° 2° 3° | Laboratorio di archeologia sull'instrumentum domesticum | F |
Giuliana Maria Facchini
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Laboratorio di greco antico | F |
Dino Piovan
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Storia del teatro greco e romano (i) | D |
Gherardo Ugolini
(Coordinatore)
|
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Estetica (p) | D |
Markus Georg Ophaelders
(Coordinatore)
|
|
| 3° | Storia romana (p) | D |
Attilio Mastrocinque
|
|
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente | |
|---|---|---|---|---|
| 2° 3° | Letteratura greca (p) | D |
Guido Avezzu'
|
|
| 2° 3° | Storia del vicino oriente antico (i) | D |
Simonetta Ponchia
|
|
| 1° 2° 3° | Archeologia e storia dell'arte greca e romana (p) | D |
Giuliana Maria Facchini
|
|
| 1° 2° 3° | Epigrafia della produzione e della distribuzione | F |
Alfredo Buonopane
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° 3° | Europa: eredità-identità-prospettive | F |
Gian Paolo Romagnani
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° 3° | Laboratorio di archeologia sull'instrumentum domesticum | F |
Giuliana Maria Facchini
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° 3° | Laboratorio di critica teatrale e musicale | F |
Simona Brunetti
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° 3° | Laboratorio di greco antico | F |
Dino Piovan
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° 3° | Seminario cres | F |
Corrado Viola
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° 3° | Storia dell'arte contemporanea (p) | D |
Roberto Pasini
|
|
Introduzione allo studio del linguaggio LT (i) (2017/2018)
Codice insegnamento
4S02162
Docenti
Coordinatore
Crediti
12
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
Periodo
Sem. 1A, Sem. 1B
Obiettivi formativi
Si organizzano corsi propedeutici in settembre con frequenza obbligatoria.
Le esercitazioni partiranno dalla seconda settimana di ottobre per tutta la durata del corso
La frequenza del corso e delle esercitazioni è altamente consigliata.
Questo corso ha lo scopo di fornire alcune conoscenze introduttive relative ai vari aspetti del linguaggio umano. L’insegnamento si propone di fornire le basi epistemiche e metodologiche della linguistica generale e della linguistica storica. A tal fine, verranno illustrati alcuni concetti cardine della moderna scienza del linguaggio, quali la distinzione fra linguaggio e lingue e l’articolazione in livelli di analisi, e descritti i principali fenomeni fonologici, morfosintattici e semantici in prospettiva di analisi sincronica e con riferimento sia all’italiano che ad altre lingue tipologicamente e genealogicamente distanti fra loro. Si discuteranno inoltre i principali fenomeni di mutamento e contatto linguistico in chiave diacronica.
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà essere in grado di analizzare il sistema dei suoni della lingua italiana, trascrivere enunciati in IPA, analizzare la struttura e il significato delle parole e dei sintagmi e frasi della propria lingua. Dovrà inoltre riconoscere i principali fenomeni di mutamento linguistico articolato sui diversi livelli di analisi (fonetico, morfologico, lessicale e semantico, sintattico), individuare i casi di contatto linguistico a livello lessicale e sintattico, la classificazione tipologica e genealogica delle lingue, quella dei dialetti italiani, e i fenomeni in variazione sincronica.
Programma
Introduzione alla linguistica generale e storica. 1) Linguistica generale (prof.ssa Melloni): caratteristiche fondamentali del linguaggio umano; nozioni di fonetica e fonologia, morfologia, sintassi, semantica e pragmatica. 2) Linguistica storica (prof.ssa Cotticelli): nozioni di mutamento, parentela e famiglia linguistica, analogia, le lingue indoeuropee e le famiglie linguistiche del mondo; modelli classificatori delle lingue, modelli per l’interpretazione del mutamento linguistico (neogrammatico, geolinguistico, sociolinguistico), il contatto linguistico.
1) G. Graffi - S. Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, nuova edizione, Bologna, Il Mulino, 2013 (capitoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 e l’Appendice).
Esercizi relativi a tutti i capitoli del volume, ed in particolare esercizi di trascrizione fonetica (il cui svolgimento verrà richiesto in sede di esame), sono disponibili sul sito della casa editrice “Il Mulino” (www.mulino.it), registrandosi nell’area denominata “Aulaweb”.
2) G. Graffi - S. Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, nuova edizione, Bologna, Il Mulino, 2013 (capitoli 3, 9, 10).
R. Lazzeroni, “Il mutamento linguistico”, in R. Lazzeroni (a cura di) Linguistica storica, 16^ ristampa 2011, Carocci, 14-54.
R. Gusmani, “Interlinguistica”, in R. Lazzeroni (a cura di) Linguistica storica, 16^ ristampa 2011, Carocci, 87-114.
3) Opera di consultazione:
Lessico di Linguistica, a cura di Paola Cotticelli Kurras, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2007.
MODALITA’ DIDATTICHE
Con riguardo agli studenti frequentanti:
1. le modalità didattiche consistono in LEZIONI FRONTALI dedicate alla trasmissione delle nozioni basilari, delle categorie-chiave e degli strumenti applicativi fondamentali.
2. L’insegnamento prevede inoltre un MODULO di lezioni INTRODUTTIVO utili a trasmettere le conoscenze basilari di lessico e grammatica. Tali lezioni saranno svolte dal 18 al 22 settembre secondo il calendario pubblicato sugli avvisi.
3. A ciò si aggiungono le ESERCITAZIONI che saranno tenute da un collega il lunedì per la durata di complessive 18 ore, sulla base di un calendario che verrà definito durante lo svolgimento delle lezioni teoriche. Le esercitazioni sono utili all’implementazione delle conoscenze teoriche e prevedono lo svolgimento e la correzione in aula di esercizi che saranno oggetto della prova scritta finale.
4. Inoltre, grazie alla piattaforma e-learning di Ateneo, sono resi disponibili tutti i materiali audiovisivi utilizzati a lezione, nonché dispense corredate da numerosi dati empirici, che costituiscono parte integrante dei materiali di studio per il superamento della prova finale. La piattaforma e-learning prevede l’implementazione di test di autovalutazione che verranno somministrati durante l’insegnamento.
Durante tutto l’anno accademico, inoltre, è disponibile il servizio di ricevimento individuale gestito dai docenti del corso, negli orari indicati sulle pagine web e costantemente aggiornati.
Gli studenti frequentanti riceveranno alla prima lezione il calendario completo delle attività didattiche con le date e gli argomenti trattati nelle lezioni di cui viene fornito l’orario, l’aula e l’indicazione dell’eventuale sospensione per motivi accademici del docente.
Con riguardo agli studenti non frequentanti, le modalità didattiche consistono in un supporto del docente ad uno studio manualistico aggiornato. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno resi disponibili in tempo utile allo studente anche mediante avvisi appositamente dedicati.
Il contenuto dei libri di testo, nonché delle lezioni ed esercitazioni tenute in aula è aderente al programma.
Ulteriore materiale didattico è disponibile sulla piattaforma e-learning dell’insegnamento.
| Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Graffi, Giorgio; Scalise, Sergio | Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica (Edizione 3) | Il Mulino, Bologna | 2013 | 9788815241795 | |
| P. Cotticelli Kurras (a cura di) | Lessico di Linguistica. Fondato da H. Bußmann. Traduzione italiana, adattamento e revisione sulla base della 3^ edizione originale, rivista e ampliata a cura di P. Cotticelli Kurras. | Edizioni dell´Orso | 2007 | 88-7694-959-3 | |
| R. Lazzeroni | Linguistica storica | Carocci | 2011 |
Modalità d'esame
Colloquio orale, preceduto da una prova scritta, costituita da una breve trascrizione fonetica e da domande sia a risposta chiusa che a risposta aperta vertenti su tutto il programma. Il superamento della prova scritta determina l’ammissione alla prova orale.
Avvertenza importante: al fine del superamento dell’esame scritto, è necessario dimostrare di essere in possesso delle nozioni grammaticali di base (es., sapere individuare il “soggetto”, “predicato”, “complemento oggetto”, ecc., di una frase, individuare i vari tipi di proposizioni subordinate, saper riconoscere correttamente le varie parti del discorso, ecc.). Tali nozioni sono reperibili su qualunque buona grammatica di scuola media o scuola media superiore; saranno comunque organizzate alcune esercitazioni apposite, con riferimenti bibliografici anche per non frequentanti.
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Prova finale
(a) La prova finale per il conseguimento del titolo consiste nella discussione di un elaborato scritto, di circa 30 cartelle di 2500 battute, su un argomento concordato con il/la relatore/trice. Alla prova finale sono riservati 6 (sei) CFU.
(b) La decisione di voto avviene senza la presenza dello/a studente/essa o di estranei/e. La Commissione dispone di centodieci punti; il voto minimo per il superamento dell’esame è di 66/110. Alla prova finale è attribuito il punteggio massimo di cinque/110.
(c) Il Collegio Didattico del Corso di laurea incentiva il compimento degli studi nella durata normale del corso (ovvero nella durata concordata, per gli/le studenti/esse a tempo parziale) assegnando un punto su 110 aggiuntivo a chi si laurei nelle sessioni dell’ultimo anno di corso. Ai soli effetti di questa incentivazione, agli/alle studenti/esse che abbiano trascorso un periodo di studio all’estero nel quadro degli scambi promossi dall’Ateneo, la durata del corso di studi normale è incrementata della durata del periodo trascorso all’estero. Se uno/a studente/essa ha speso all’estero un periodo di studio entro il quadro di un accordo Erasmus, viene aggiunto 1 punto su 110 alla media pesata.
(d) Quando il/la candidato/a abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere concessa la lode purché con decisione unanime.
(e) L’elaborato scritto, oggetto della prova finale, può essere redatto in lingua diversa dall’Italiano, previa approvazione del/della relatore/trice e del/della Presidente del Collegio Didattico. La discussione deve comunque essere condotta in Italiano.
L’elaborato scritto verrà caricato on line dal/dalla candidato/a e dovrà essere approvato dal/dalla relatore/trice prima della sua discussione.
Le discussioni dell’elaborato finale avvengono davanti a sottocommissioni di almeno tre membri, dei quali uno sarà il/la relatore/trice, uno il/la correlatore/trice, il terzo un altro/a docente dell’Ateneo oppure un esperto/a esterno/a nominato/a dal Presidente del Collegio didattico. La discussione si svolgerà nei giorni precedenti la proclamazione in data concordata dai/dalle componenti la sottocommissione. Il risultato della discussione e la proposta di valutazione saranno tempestivamente comunicati dal/dalla Presidente della sottocommissione al/alla Presidente della Commissione per la prova finale.
La Commissione per la prova finale procederà alla valutazione, tenendo conto della proposta delle sottocommissioni, alla proclamazione e alla comunicazione del voto di laurea. La verbalizzazione, da compilarsi secondo la procedura denominata “firma digitale”, sarà responsabilità del/della Presidente della Commissione.
La commissione, constatato il valore insufficiente dell’elaborato, lo può ricusare: in tal caso lo/la studente/essa dovrà migliorare l'elaborato o comporne uno diverso, presentandosi ad una successiva sessione di laurea.
Lo/la studente/essa può ritirarsi dall’esame finale fino al momento di essere congedato dal/dalla Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto.
Per gli studenti del Corso di laurea in Lettere, l'Esame di laurea si svolge in due momenti distinti:
- la discussione dell’elaborato finale, durante le due settimane precedenti la proclamazione;
- la proclamazione di laurea, in un giorno del periodo previsto dal calendario didattico per l'Esame di laurea.
N.B. Può essere relatore di elaborati per il conseguimento del titolo ogni docente che faccia parte del Collegio didattico di Beni culturali, Lettere e Tradizione e interpretazione dei testi letterari, purché lo studente abbia superato durante il corso di studio un esame in una disciplina del settore scientifico-disciplinare di afferenza del docente stesso.
Adempimenti amministrativi e scadenze domanda di laurea
Calendari discussione e proclamazione di laurea
Elenco delle proposte di tesi
| Proposte di tesi | Area di ricerca |
|---|---|
| tesi di Glottologia, Storia comparata, Linguistica storica | ENGLISH LANGUAGE - Grammar and Syntax – Grammatik und Syntax |
| tesi di Glottologia, Storia comparata, Linguistica storica | GERMANIC LANGUAGE - Dialectology - Dialektologie |
| tesi di Glottologia, Storia comparata, Linguistica storica | HUMANITIES & SOCIAL STUDIES - HUMANITIES & SOCIAL STUDIES |
| tesi di Glottologia, Storia comparata, Linguistica storica | Indo-European languages & literatures - Indo-European languages & literatures |
| tesi di Glottologia, Storia comparata, Linguistica storica | LINGUISTICS - LINGUISTICS |
Gestione carriere
Esercitazioni Linguistiche CLA
Tutorato per studenti
Tutti i docenti del Corso di Studio possono fornire nell'orario di ricevimento una forma di tutorato volta ad orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi.Requisiti classi di abilitazione insegnamento
Requisiti necessari per accedere alle classi di abilitazione per l'insegnamento.
vedi allegato pdf
Inoltre, per informazioni sui 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, si veda -> LINK
Documenti
| Titolo | Info File |
|---|---|
|
|
pdf, it, 307 KB, 30/11/21 |














































