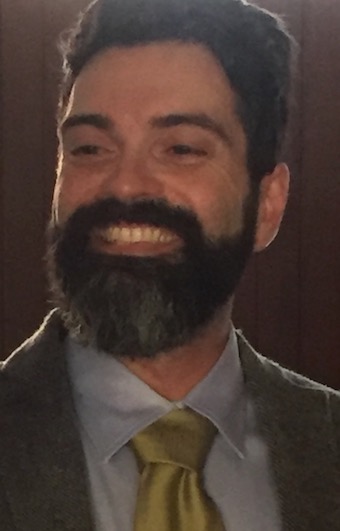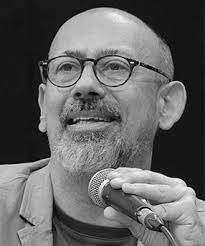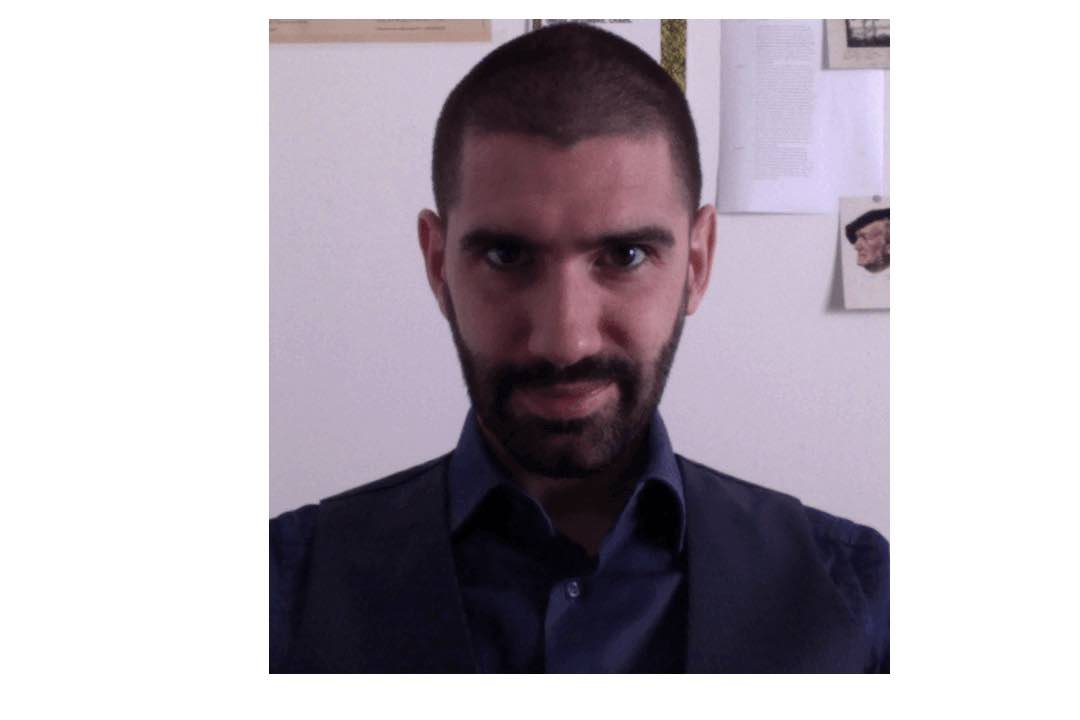Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sem. 1A | 27-set-2021 | 6-nov-2021 |
| Sem. 1B | 15-nov-2021 | 12-gen-2022 |
| Sem. 2A | 14-feb-2022 | 26-mar-2022 |
| Sem. 2B | 4-apr-2022 | 4-giu-2022 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione Invernale | 10-gen-2022 | 12-feb-2022 |
| Sessione estiva | 6-giu-2022 | 23-lug-2022 |
| Sessione autunnale | 29-ago-2022 | 24-set-2022 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione estiva | 11-lug-2022 | 16-lug-2022 |
| Sessione autunnale | 7-nov-2022 | 12-nov-2022 |
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| FESTIVITA' OGNISSANTI | 1-nov-2021 | 1-nov-2021 |
| Festa dell'Immacolata | 8-dic-2021 | 8-dic-2021 |
| Vacanze di Natale | 25-dic-2021 | 6-gen-2022 |
| VACANZE DI PASQUA | 15-apr-2022 | 19-apr-2022 |
| Festa della Liberazione | 25-apr-2022 | 25-apr-2022 |
| FESTA DEL LAVORO | 1-mag-2022 | 1-mag-2022 |
| Festività Santo Patrono di Verona | 21-mag-2022 | 21-mag-2022 |
| Festa della Repubblica | 2-giu-2022 | 2-giu-2022 |
| Vacanze estive | 8-ago-2022 | 15-ago-2022 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria Corsi di Studio Scienze Umane.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Docenti
 francesco.bianchi@univr.it
francesco.bianchi@univr.it
 evita.calabrese@univr.it
evita.calabrese@univr.it
 andrea.cavalletti@univr.it
andrea.cavalletti@univr.it
 elena.desilvestri@univr.it
elena.desilvestri@univr.it

Mastrocinque Attilio
 attilio.mastrocinque@univr.it
attilio.mastrocinque@univr.it
 +39 045802 8386
+39 045802 8386
 stefania.pontrandolfo@univr.it
stefania.pontrandolfo@univr.it
 pieralberto.porcedducilione@univr.it; pierre_pordd@yahoo.it
pieralberto.porcedducilione@univr.it; pierre_pordd@yahoo.it
 045 8028732
045 8028732
 nicola.turrini@univr.it
nicola.turrini@univr.it
 mariarenata.zanchin@univr.it
mariarenata.zanchin@univr.it
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Lingua straniera competenza linguistica liv. b1 (informatizzato)Altre attivita' formative2° Anno Attivato nell'A.A. 2022/2023
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Un insegnamento a sceltaTre insegnamenti a scelta3° Anno Attivato nell'A.A. 2023/2024
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Tre insegnamenti a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Lingua straniera competenza linguistica liv. b1 (informatizzato)Altre attivita' formative| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Un insegnamento a sceltaTre insegnamenti a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Tre insegnamenti a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Due insegnamenti a scelta Tre insegnamenti a scelta Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Antropologia culturale (2022/2023)
Codice insegnamento
4S007523
Docente
Coordinatore
Crediti
6
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
M-DEA/01 - DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
Periodo
Sem. 2A dal 13-feb-2023 al 30-mar-2023.
Obiettivi di apprendimento
Conoscenza e comprensione:
- conoscere e comprendere le problematiche legate alla diversità culturale;
- conoscere le principali tappe del pensiero antropologico in ambito socio-culturale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
- capacità di individuare e analizzare il tema della diversità culturale.
Autonomia di giudizio:
- capacità di formulare giudizi autonomi sulla genesi, la natura e il senso delle questioni affrontate durante il corso;
- sviluppare un giudizio autonomo su questioni socio-culturali specifiche.
Abilità comunicative:
- capacità di trattare la tematica dell’alterità culturale con un linguaggio appropriato.
Capacità di apprendimento:
- acquisire le conoscenze necessarie per proseguire gli studi in ambito magistrale.
Prerequisiti e nozioni di base
Il corso è introduttivo. Pertanto non sono richiesti prerequisiti agli studenti.
Programma
Contenuti:
I principali contenuti del corso seguono l’evoluzione del pensiero antropologico per tappe, a partire dalla seconda metà del XIX secolo a oggi focalizzandosi sulle seguenti scuole:
- l’antropologia evoluzionista del XIX secolo e la scuola americana;
- l’antropologia francese e lo studio delle “società primitive”;
- L’etno-sociologia francese;
- Lo sviluppo dell’antropologia culturale statunitense;
- Malinowski e le origini del metodo etnografico;
- Il funzionalismo strutturale britannico;
- L’antropologia strutturale di Lévi-Strauss;
- Le teorie interazioniste;
- L’antropologia marxista;
- La svolta interpretativa;
- Principali dibattiti e questioni contemporanee.
L’esposizione delle suddette tematiche permetterà di introdurre lo studente a:
- le principali acquisizioni dell'antropologia riguardo alla visione del mondo e alla creatività umana: dal mito al rituale, dalla religione alla dimensione cognitiva;
- la prospettiva antropologica sulle dimensioni più sociali della vita umana quali la famiglia, il potere, la politica, l’economa e le forme di organizzazione umana;
- il contributo della disciplina allo studio della vita umana nella società complessa contemporanea.
Bibliografia
Modalità didattiche
Il corso si basa su lezioni frontali in presenza supportate da contenuti multimediali (slide, video, e foto) e l’esplorazione di casi etnografici.
La registrazione delle lezioni sarà resa disponibile dal docente fino alla fine del corso.
Nota: Le attività didattiche possono essere svolte, oltre che in presenza di docenti e studenti, anche con modalità a distanza nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni adottate dagli organi di Ateneo.
Testi di riferimento:
1. Ugo Fabietti, 2020, Storia dell'antropologia, 4a edizione, Zanichelli, Bologna. Studiare solo i seguenti capitoli e le relative pagine:
- capitolo 1 (da p. 14 a p. 21)
- capitolo 2 (tutto tranne pp. 32 e 33)
- capitolo 4 (da p. 44 a p. 47)
- capitolo 6 (p. 56 e da fondo di p. 58 a p. 63)
- capitolo 8 (da p. 74 a metà di p. 78, e p. 82)
- capitolo 9 (da p. 86 a metà di p. 89, e da fondo di p. 90 a metà di p. 95)
- capitolo 13 (da p. 124 a metà di p. 126, e da p. 130 a p. 132)
- capitolo 14 (da p. 133 a p. 136, e da fondo di p. 138 a p. 143)
- capitolo 17 (tutto tranne p. 178)
- capitolo 18 (da p. 181 a metà di p. 185, e da p. 189 a p. 190)
- capitolo 19 (da p. 191 a p. 192, da metà di p. 194 a metà di p. 198, e da p. 200 a p. 202)
- capitolo 20 (fino a prime righe di p. 221).
2. Un testo a scelta tra i seguenti due:
- Edward E. Evans Pritchard, 2002, Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande, Raffaello Cortina, Milano (Nota: studiare solo da p. 1 a p. 190).
- Marcel Mauss, 2002, Saggio sul dono, Einuadi, Introduzione di Marco Aime.
Modalità di verifica dell'apprendimento
L’esame consiste in una unica prova orale. La verifica degli apprendimenti non prevede differenze tra studenti frequentanti e non frequentanti.
La prova orale prevede la somministrazione allo studente di domande aperte.
Nota: Le modalità di accertamento possono essere svolte, oltre che in presenza di docenti e studenti, anche con modalità a distanza nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni adottate dagli organi di Ateneo.
Criteri di valutazione
Lo studente dovrà dimostrare di:
- aver compreso le principali correnti del pensiero antropologico dalle origini ai giorni nostri;
- saper collocare le nozioni chiave e i principi base della disciplina all’interno delle suddette correnti;
- essere in grado di sintetizzare ed esporre in modo rigoroso le proprie argomentazioni dimostrando la capacità di usare un linguaggio antropologico adeguato;
- saper associare a ogni argomentazione e sintesi teorica uno o più esempi etnografici, fra quelli trattati in classe e/o riscontrati nella monografia, coerenti con l’argomento trattato.
Criteri di composizione del voto finale
La valutazione della prova di accertamento avrà luogo in trentesimi.
Lingua dell'esame
Italiano
Tipologia di Attività formativa D e F
Una quota dei crediti corrispondenti all’attività formativa dell’intero triennio, determinata dal presente Regolamento in 12 CFU, è riservata alla scelta autonoma da parte della/o studente. Questa scelta può essere orientata sia verso corsi/esami non seguiti/sostenuti in precedenza, sia verso iterazioni di corsi/esami, sia ancora verso altre attività (tutorati, ulteriori competenze linguistiche, partecipazione a convegni o seminari), purché tutte preventivamente approvate dal Collegio Didattico e/o dalla Commissione Didattica del Dipartimento. Tra i 12 crediti dovrà comunque essere presente almeno un esame con voto. In conformità al dettato del D.M. 270/04 e alla luce delle raccomandazioni espresse dal D.M. 26 luglio 2007, capo 3 lettera n), la scelta, che non può essere predeterminata (fatto salvo quanto indicato per le iterazioni), deve comunque essere ispirata a coerenza col piano formativo della/del singola/o studente.
In caso di attività formative non rientranti nelle categorie previste, si dovrà fare richiesta di valutazione al Collegio Didattico di Filosofia fornendo adeguate motivazioni.
Altre informazioni sono reperibili nella Guida per i crediti liberi che è possibile trovare quì
COMPETENZE TRASVERSALI
Scopri i percorsi formativi promossi dal Teaching and learning centre dell'Ateneo, destinati agli studenti iscritti ai corsi di laurea, volti alla promozione delle competenze trasversali:
https://talc.univr.it/it/competenze-trasversali
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° 3° | Ciclo tematico di conferenze “Quali paradigmi oltre la pandemia?" | D |
Paola Dal Toso
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Il contagio e la cura. Il mondo dopo il virus | D |
Carlo Chiurco
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Workshop “l’etica e l’estetica dell’immagine” | D |
Gianluca Solla
(Coordinatore)
|
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° 3° | Ciclo tematico di conferenze “Quali paradigmi oltre la pandemia?" | D |
Paola Dal Toso
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Il contagio e la cura. Il mondo dopo il virus | D |
Carlo Chiurco
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Laboratorio “Calendario di Memoria Civile – Giornata della Memoria” | D |
Olivia Guaraldo
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Seminari Tiresia 2021/2022 (“Eros e Polis” e “Nel nome di Tiresia: Soggettivazione, transito, sessuazione”) | D |
Federico Leoni
(Coordinatore)
|
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° 3° | Introduzione alla robotica per studenti di materie umanistiche | D |
Paolo Fiorini
(Coordinatore)
|
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° 3° | Centro di studi politici "Hannah Arendt" - Seminari | D |
Ilaria Possenti
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Ciclo di incontri dal titolo “La Giustizia riparativa” | D |
Cristina Lonardi
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Giornata di studi di “Psicologia delle masse cent’anni dopo: legame sociale e nuove forme di soggettivazione” | D |
Matteo Bonazzi
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Il contagio e la cura. Il mondo dopo il virus | D |
Carlo Chiurco
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Laboratorio di Gnoseologia e Metafisica | D |
Davide Poggi
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Seminari Tiresia 2021/2022 (“Eros e Polis” e “Nel nome di Tiresia: Soggettivazione, transito, sessuazione”) | D |
Federico Leoni
(Coordinatore)
|
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° 3° | Centro di studi politici "Hannah Arendt" - Seminari | D |
Ilaria Possenti
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Giustizia partecipata e riforme. La composizione dei conflitti con le persone e per le persone | D |
Cristina Lonardi
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Laboratorio di Gnoseologia e Metafisica | D |
Davide Poggi
(Coordinatore)
|
| 1° 2° 3° | Seminari Tiresia 2021/2022 (“Eros e Polis” e “Nel nome di Tiresia: Soggettivazione, transito, sessuazione”) | D |
Federico Leoni
(Coordinatore)
|
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Tutorato per gli studenti
Gli iscritti al CdS in Filosofia possono rivolgersi al personale docente docente nell'orario di ricevimento per parlare delle eventuali difficoltà di cui fanno esperienza nel cammino formativo, nell’organizzazione del piano didattico, nella preparazione degli esami e in tutte le altre situazioni in cui può essere utile farsi aiutare nelle proprie scelte o ricevere un consiglio da persone consapevoli dei vari dettagli della vita accademica, dei processi e dell’architettura del CdS.
I docenti indicati come tutor del corso di laurea in Filosofia sono:
- prof. Federico Leoni;
- prof. Davide Poggi;
- prof.ssa Ilaria Possenti.
Nel quadro del programma di TUTORATO, il Dipartimento di Scienze Umane ha inoltre deciso di utilizzare l’esperienza di alcuni iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche per offrire un supporto che sia il più vicino possibile a chi frequenta il CdS triennale, sulla base della loro diretta esperienza.
Tali Tutor studenteschi forniranno un servizio di orientamento, sia in ingresso (vòlto a favorire un migliore inserimento nei Corsi di Studio, ovviando alle difficoltà e agli ostacoli che il passaggio dalla Scuola Superiore all’Università inevitabilmente comporta), sia in itinere, così da offrire un servizio di sostegno che sappia adeguatamente interpretare e rispondere alle esigenze di formazione e professionalizzazione, nonché alla sensibilità di chi frequenta i CdS filosofici.
Tra i compiti e le attività previste vi sono:
- Sostegno nella compilazione dei piani didattici, consulenza nella risoluzione di problemi amministrativi (reperimento informazioni sul sito web di Ateneo);
- Individuazione e suggerimento di Uffici e Responsabili competenti in relazione alle questioni segnalate, etc.;
- Aiuto per una migliore e più agile gestione del proprio iter formativo (supporto in merito all’accesso e alla fruizione della didattica on-line attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Ateneo);
- Orientamento delle/degli studenti (inclusa la scelta del docente per la tesi) in vista della prova finale di laurea;
- Svolgere attività di orientamento delle future matricole (su appuntamento via Zoom) coordinata dall’Ufficio Orientamento, anche tramite incontri nei mesi di settembre e ottobre;
- Gestione delle pagine social dedicate alle/agli studenti;
- Tutorial a distanza per supporto metodo di studio/tesi;
- Orientamento della/o studente all’uso del supporto prodotto dal sistema bibliotecario di Ateneo e aiuto alle/ai laureandi per reperire le fonti bibliografiche in caso consultazione materiale bibliografico non disponibile on-line;
- Indagine per la rilevazione di difficoltà dovute all'emergenza in corso;
- Tutorial per il sito del CdS di riferimento;
- Diffusione/pubblicizzazione di comunicazioni/informazioni di maggior importanza/utilità relativamente al CdS e alle sue attività/iniziative (bandi di tutorato/bandi di internazionalizzazione/etc.).
I Tutor studenteschi, tramite la casella di posta elettronica istituzionale, cercheranno di raggiungere le matricole per organizzare insieme una serie di colloqui informali e programmare eventuali iniziative sotto la supervisione dei Tutor accademici.
Per l'a.a. 2023-2024 sono stati nominate come Tutor per il CdS in Filosofia
- Cristian Meneghetti, cristian.meneghetti@studenti.univr.it disponibilità ricevimento: il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
- Michela Marcomini, michela.marcomini@studenti.univr.it disponibilità ricevimento: il giovedì dalle 15.00 alle 16.00
I ricevimenti si terranno in presenza previo appuntamento via e-mail presso la Sala Seminari 2, secondo piano del Palazzo di Lettere.
Eventuali variazioni di giorno e/o orario saranno comunicate con il dovuto anticipo mediante avvisi sulla pagina web di Ateneo.
Esercitazioni Linguistiche CLA
Gestione carriere
Guide operative per lo studente
In questa pagina lo studente potrà trovare delle guide operative, utili al completamento del proprio percorso universitario, che vanno ad integrare quanto già indicato nei Regolamenti didattici del CdS.
1- Qui si possono reperire indicazioni in merito ai riconoscimenti di carriera, ai crediti a libera scelta per lo studente e alle certificazioni linguistiche per gli studenti iscritti ai CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umane a partire dalla coorte 2022 (le indicazioni contenute nella Guida entrano in vigore dal 29 marzo 2023 e sono retroattive solo se a favore dello studente);
2 - Qui si possono reperire indicazioni in merito ai riconoscimenti di carriera, ai crediti a libera scelta per lo studente e alle certificazioni linguistiche per gli studenti iscritti ai CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umane a partire dalla coorte 2014 (le indicazioni contenute nella Guida entrano in vigore dal 29 aprile 2020 e sono retroattive solo se a favore dello studente);
3 - Qui si possono reperire indicazioni in merito al conseguimento dei crediti a libera scelta (Crediti D e F) per gli studenti iscritti ai i CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umane fino alla coorte 2013 (le indicazioni contenute nella Guida entrano in vigore dal 23 febbraio 2011 e sono retroattive solo se a favore dello studente).
Documenti
| Titolo | Info File |
|---|---|
|
|
pdf, it, 325 KB, 16/07/24 |
|
|
pdf, it, 212 KB, 02/05/23 |
|
|
pdf, it, 131 KB, 02/05/23 |
Prova Finale
Per conseguire la laurea in Filosofia, la/lo studente dovrà superare una prova finale. Essa potrà avvenire dopo almeno venti giorni dal superamento delle prove di valutazione relative a tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto dal proprio piano di studi.
La prova finale, cui sono attribuiti 6 CFU, consiste in un elaborato scritto volto ad approfondire una tematica concordata colla/col relatrice/relatore. La tematica dell’elaborato dovrà essere inerente al curriculum della/o candidata/o. La lunghezza dell’elaborato dovrà essere compresa tra venti e trenta cartelle. La/lo studente dovrà avvalersi della supervisione della/o relatrice/relatore, che può essere qualunque docente appartenente all’Ateneo, incluse/i le/i docenti a contratto. La/lo studente dovrà aver superato almeno un esame afferente al settore scientifico-disciplinare di appartenenza della/o relatrice/relatore. Non è prevista la figura della/o correlatrice/correlatore.
L’elaborato potrà essere redatto anche in lingua diversa dall’italiano, previa approvazione della/o relatrice/relatore e del Collegio Didattico, ma la discussione dovrà comunque essere condotta in italiano. La/lo studente potrà ritirarsi dall’esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto. Il Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce le procedure alle quali attenersi nel caso in cui la/il candidata/o non consegua il punteggio minimo richiesto.
La discussione della prova finale avviene in un periodo di tempo che precederà la proclamazione. Il giorno e l’orario preciso della discussione verranno comunicati alla/o laureanda/o dal/la propria/o relatrice/relatore.
La discussione sarà effettuata con una Commissione Istruttoria composta dal/la relatrice/relatore della/o laureanda/o ed un/a altra/o docente, e potrà avvenire in modalità telematica nel caso del protrarsi dell’emergenza da SARS-CoV-2. Superata la discussione della tesi con la Commissione Istruttoria, la proclamazione con comunicazione del voto di laurea avverrà nel periodo indicato nel calendario didattico. Il giorno, l’ora e le modalità di proclamazione saranno resi noti con la pubblicazione del Calendario Lauree commissioni Triennali.
La commissione dispone di centodieci punti; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110, mentre il voto di partenza è dato dalla media ponderata dei voti degli esami. Il voto viene assegnato dalla commissione in assenza della/o candidata/o e di ogni altro estraneo. Nell’assegnazione del voto alla prova finale, la commissione, valutato anche il curriculum della/o candidata/o, si atterrà ai seguenti criteri, attribuendo:
- fino a cinque punti per la dissertazione;
- in rispetto, e ampliamento, di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale, il Collegio Didattico di Filosofia incentiva l’internazionalizzazione assegnando 2 (due) punti su 110 aggiuntivi alle/agli studenti che abbiano conseguito almeno 2 CFU all’estero;
- un punto per il compimento in corso degli studi;
- un punto se la/lo studente ha proseguito al II anno nel corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno.
Nel caso in cui la/il candidata/o abbia ottenuto il massimo dei voti, la commissione può concedere, all’unanimità, la distinzione della lode.
Documenti
| Titolo | Info File |
|---|---|
|
|
pdf, it, 109 KB, 12/07/24 |
|
|
pdf, it, 112 KB, 14/05/24 |
Elenco delle proposte di tesi
Stage e Tirocini
Area riservata studenti
Modalità e sedi di frequenza
La frequenza non è obbligatoria.
Maggiori dettagli in merito all'obbligo di frequenza vengono riportati nel Regolamento del corso di studio disponibile alla voce Regolamenti nel menu Il Corso. Anche se il regolamento non prevede un obbligo specifico, verifica le indicazioni previste dal singolo docente per ciascun insegnamento o per eventuali laboratori e/o tirocinio.
È consentita l'iscrizione a tempo parziale. Per saperne di più consulta la pagina Possibilità di iscrizione Part time.
Le sedi di svolgimento delle lezioni e degli esami sono le seguenti
- Polo Zanotto (vicino si trova il Palazzo di Lettere)
- Palazzo ex Economia
- Polo Santa Marta
- Istituto ex Orsoline
- Palazzo Zorzi (Lungadige Porta Vittoria, 17 - 37129 Verona)
- Chiostro Santa Maria delle Vittorie, Lungadige Porta Vittoria, 41